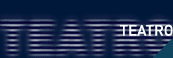 |
| |
Dialogo settimanale su teatro e danza.
ANNO 2024 NUMERO 35
Dal 06/05/2024
al 13/05/2024
Aggiornato il lunedì sera
|
|
 |
 |
 |
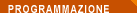 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
| Tu es le fils de quelqu’un |
|
| Editoriale (lungo) a vantaggio di coloro che parlano troppo |
|
|
|
|
di Gian Maria Tosatti
|
|
|
|
|
Trovo da tempo assai importante la riflessione sul rapporto fra maestri e allievi. Fra nutrimento e vomito. Tra formazione e identità.
Al presente si rileva in Italia un assoluto scollamento tra la richiesta del mercato e la logica intima dei “veri” processi artistici.
Il mercato e chi ne definisce le richieste, pretende, oggi, essenziamente tre cose: la perfezione, l’assoluta ed integrale originalità e il basso costo.
Così espresso salta all’occhio del più miope fra i lettori che la proposta sia semplicemente assurda… E’ come cercare di comprare un cavallo che abbia le ali, un corno piantato sulla fronte e che costi massimo 1.000 euro.
Ma per supportare tale osservazione “reazionaria” mi piace citare una frase da una conversazione che ebbi con Iben Nagel Rasmussen, membro storico e anima-madre dell’Odin Teatret. In una mattina d’autunno di qualche anno fa Iben mi raccontava degli inizi all’Odin e del rapporto di stana convivenza tra le due anime di quello che era l’Odin di allora, ovvero gli attori del gruppo da una parte e Jerzy Grotowski, il “maestro invisibile”, dall’altra. In mezzo Eugenio Barba, leader e trait d’union fra queste due anime. Quello che mi incuriosiva era il senso di sofferenza da parte degli attori rispetto all’aleggante spirito di Grotowski, presente nella pratica e anche nell’estetica di quel giovane gruppo, ma assente fisicamente, incontrato solo dopo alcuni anni nel mese estivo che ad Holstebro si dedica ai laboratori.
br>
Verso la metà del racconto arrivammo al capitolo glorioso di quello che è stato forse uno dei più importanti spettacoli del Novecento, ovvero Min Fars Hus (La casa del padre). Allora Iben mi disse: “Quello è stato lo spettacolo in cui finamente ci liberammo del peso dell’eredità di Grotowski”. Feci un calcolo volante e tenendo conto che l’Odin fece il suo primo spettacolo nel 1964, mentre Min Fars Hus è del ’71 contai sette anni fra la nascita del gruppo e un evento che per l’Odin segnava congiuntamente la realizzazione di un capolavoro e il raggiungimento di una integrale originalità.
Ci sono voluti sette anni per raggiungere i due risultati (del basso costo non ci occuperemo), ma non si può neppure dire che una volta preso il via l’Odin abbia collezionato un grande slam di capolavori. Nei quarant’anni (compiuti da pochi giorni) della sua storia lavori eccellenti come Min Far Hus, Le ceneri di Brecht o Itsi bitsi si sono alternati con creazioni destinate a stare in seconda fila…
Ma quel che era importante sottolineare era l’altro aspetto. I sette anni per liberarsi dell’eredità di Grotowski.
Tuttavia quest’espressione detta così non è certo corretta. Perché quell’eredità è ancora viva ad oggi. Solo che ne è rimasto un retaggio intimo, diventato tutt’uno con l’esperienza individuale di quegli artisti. Quello che si è perso è la riconoscibilità di certi segni teatrali, di certi cenni estetici. Si è persa la dipendenza ad un modello.
Ma allora cosa è rimasto di quell’eredità? Moltissimo. In primo luogo l’indipendenza rispetto ad essa. In secondo luogo è rimaso senso e di conseguenza i suoi modi. Sono rimaste le domande.
Pensando al lavoro dei giovani registi mi vengono in mente i primi pasti di una creatura a digiuno. In bilico precario tra l’abbuffata e la nausea. Mangiare a ingozzarsi per la fame e vomitare per la disabitudine al cibo. Un moto naturale finché il bios non trova il modo di scindere le molecole del nutrimento nella maniera ottimale per cui tutta l’energia del nutrimento venga assimilata e si trasformi in energia vitale. In base a questa energia l’uomo diventa “attivo” e la sua creazione qualcosa di originale. Ma queste sono le tappe appunto di un percorso, che a volte, forse nelle esperienze più luminose porta i primi frutti considerevoli dopo sette anni, ma che talvolta anche dopo quella data non è esaurito.
Qualche giorno fa assisto ad una replica dello spettacolo: Gospels of Childhood (I vangeli dell’infanzia), ad opera di Jaroslaw Fret, regista del Teatr Zar e direttore del Centro Grotowski di Wroclaw, che per età e per anni di lavoro con il suo gruppo (quattro) si trova nel centro ideale di quel cammino, a metà fra vomito e assimilazione-trasformazione.
Il suo spettacolo consta di quaranta minuti davvero preziosi in cui questo artista ha creato una visione abbacinante attorno all’epserienza della Resurrezione, di quelle figure evangeliche che hanno suggestionato la nostra immaginazione infantile con tinte quasi espressionistiche, per rendere le quali il regista è andato cercando nei Vangeli apocrifi di Maria Maddalena, di Tommaso.
Quaranta minuti tecnicamente altissimi (specie per l’esecuzione di antichi canti polifinici recuperati in viaggi di ricerca nei territori della Georgia e nel Monte Athos) in cui questo giovane “maestro” ha suscitato nella mia memoria gli echi di una tradizione teatrale ancora viva e forte in Polonia. Ho ritrovato i retaggi di Grotowski e di Gardzienice e ancora di molti artisti che in quel solco si sono mossi. Ma l’impressione non è stata quella di aver visto qualcosa di vecchio, di già visto. E sì che alcuni modi, stilemi, li ritrovavo uguali nella mia memoria a spettacoli di venti anni fa. Ma non per un solo istante ho pensato di trovarmi di fronte ad un teatro di vent’anni fa. Perché la necessità di operare attraverso “quella possibilità di teatro” era una necessità presente, ardentemente attuale.
Ma il problema sta a monte. Sta nell’archiviazione dei fenomeni storici e nella loro lettura superficiale (superficialissima). Spesso ho sentito parlare di opere a me contemporanee come di opere che sanno di vecchio, che ripropongono uno stile, come ad esempio quello del “terzo teatro”, di vent’anni prima.
Un fenomeno non corrisponde necessariamente ad una moda. E di ciò possiamo rendercene conto specie se evitiamo di considerarne le dimensioni secondo un parametro cronologico. In un’analisi reale sul senso e significato del fenomeno si può arrivare a doversi rimangiare i vincoli cronologici che ne avevano ridimensionato la grandezza per farlo entrare nelle casellette di un calendario storico.
Il lavoro di Grotowski e di chi negli anni si è affiancato a lui, ad esempio, non è equiparabile ad una moda, ad un trend momentaneo. (Questo va detto una buona volta anche a vantaggio di tutti quegli intellettuali che parlano, senza aver studiato, tanto per dar ragione ai libri e che “riconoscono” Grotowski come un maestro senza “conoscerlo” affatto). Grotowski ha messo le regole di un nuovo rito teatrale. Un rito con altre necessità e con domande che non si esauriscono con una generazione o con un flusso della moda. Tornare sui suoi passi non vuol dire allora riesumare una moda, quanto piuttosto prendere possesso di una ricerca di senso attraverso una certa ritualità. Mescolando in maniera irriverente il sacro col profano viene quasi spontaneo un paragone per dire che se per un certo numero di anni dovesse sparire dalla faccia della terra il rito cattolico, e venisse poi riesumato, sarebbe assurdo affermare che l’eucarestia sia “vecchiume”, così pure come altre parti dell’omelia.
Un rito non conosce moda, un rito chiede altre regole alla partecipazione. Nessuno in una chiesa, in un tempio o in qualsiasi altro ambito simile chiede di divertirsi, o di capire la storia. In un rito si cerca e soprattutto si “impara” un modo di partecipare.
Ecco il punto. La mala educazione oggi coniste proprio in questo, nel negare di fatto che “il teatro” sia “i teatri”. E che “i teatri” non siano la differente espressione di una stessa cosa, ma differenti espressioni di differenti cose. Fino a negare qualsiasi legame col concetto di rappresentazione. Oggi coloro che chiedono il capolavoro totalmente originale e a basso costo sono anche coloro che hanno una spaventosa ansia di definire cosa sia il teatro. Di definire cosa accadrà dentro l’edificio teatrale.
Finché quest’ansia ad etichettare non sarà estinta la nostra ignoranza troverà facile sollevare la propria superbia fino a dire questo è teatro, questo non è teatro, questo è nuovo, questo è vecchio.
Personalmente credo che il valore dell’umiltà stia nel cercare di capire e non di “definire”. Stia nell’esporsi a quello che accade senza disturbare in primo luogo sé stessi. Sia di evitare la cialtroneria del giudizio. Quella cialtroneria infantile che è simpatica a otto anni (quando io dissi che non volevo andare a messa perché tanto era sempre uguale), ma che da adulti è il segno della malattia di una società.
Se questo venisse compreso allora i costruttori di teatri sarebbero in primo luogo i distruttori di codici. Sarebbero coloro che per primi si batterebbero contro le “aspettative”. Sarebbero i primi a dire che un teatro è prima di tutto una stanza con della gente dentro. Spogliando tutto, arrivando all’essenziale resterebbe appunto il teatro: un’assemblea di esseri umani. Quello che vi accade dentro non deve essere previsto.
Il lavoro di Jaroslaw Fret e del suo Teatr Zar è allora la presenza davanti a me di un rituale che ha una sua tradizione, un rituale sacro e laico al contempo, attraverso cui si può condividere il viaggio di qualcuno dentro certe domande. E’ un rituale che riconosco, ma le domande che vengono poste sono diverse. Gli uomini che lo officiano sono diversi. Del rituale resta quell’eredità formale che in altri riti permette di declinare la preghiera, di stabilire il rapporto di interazione tra gli officianti e l’assemblea di chi partecipa. Jaroslaw Fret non è il becchino che riesuma quel rito, non ne è il feticistico emulatore, non è l’esteta museale che lo ricostruisce per esporlo. Fret è il figlio di quel rito. Fret, semplicemente, “es le fils de quelqu’un” e lo sarà anche quando il suo vomitare sarà finito, quando mi sarà più difficile trovare quegli espliciti cenni, quelle parentele estetiche che oggi, comunque non mi disturbano affatto.
Ai lettori e spettatori, cui questo articolo è dedicato, resta l’ultimo pensiero dell’autore. Nei teatri, anche nei più sporchi, entrate per cercare, non per capire. Entrate per non disturbare, come quando mettete piede in templi di culti che non conoscete. A consigliarvi i teatri in cui vi farà bene “togliervi le scarpe” ci pensiamo noi.
|
|
|
|
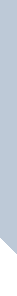 |

 L’ultimo numero di LifeGate Teatro
L’ultimo numero di LifeGate Teatro
|
Pubblichiamo oggi, 30 marzo 2005 l’ultimo numero di LifeGate Teatro, settimanale di teatro e danza che per due anni e mezzo ha compiuto la sua attività editoriale all’interno del progetto LifeGate. Sono stati mesi importanti per noi. Abbiamo cercato di cambiare il modo di fare giornalismo teatrale. Di rifondare la critica italiana cercando di capire quale fosse il suo ruolo in questo presente storico. La nostra sfida non era riuscirci. Era provarci. E forse ci abbiamo provato piuttosto bene.
On-line rimarranno gli archivi di questi due anni. Il lettore “postumo” potrà trovarvi le tracce del nostro lavoro e certamente dei contributi utili alle sue ricerche sul teatro italiano contemporaneo.
Per il numero di chiusura avevamo chiesto ai nostri lettori di scrivere qualcosa su di noi. Alcuni lo hanno fatto. E pubblichiamo i loro piccoli, ma importanti, contributi nei due articoli intitolati Bon nuit. Altri, davvero molti, hanno preferito mandarci messaggi di carattere più strettamente personale, che scegliamo di non pubblicare. Ma li ringraziamo tutti. Quelli di cui riportiamo i commenti e quelli, troppi per poterli citare, di cui conserveremo gli appelli alla resistenza, che per noi sono stimolo di trasformazione.
Per chiudere ci sembrava infine giusto puntare ancora una volta l’obiettivo su un problema centrale, quello che ha dato vita due anni e mezzo fa a questa rivista, ovvero la necessità di esigere di più dalla critica italiana. E un dovere degli artisti e noi ad essi ci rivolgiamo.
- Redazione Teatro -
|
|
| |

|
|