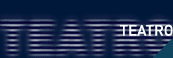 |
| |
Dialogo settimanale su teatro e danza.
ANNO 2024 NUMERO 36
Dal 13/05/2024
al 20/05/2024
Aggiornato il lunedì sera
|
|
 |
 |
 |
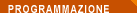 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
| Nuovi appunti illeggibili sulla Tragedia Endogonidia |
|
| Resoconto disordinato, ma doveroso dopo aver assistito a S#08, l'VIII episodio della Tragedia Endogonidia della Societas Raffaello Sanzio. |
|
|
|
Strasburgo, 17-20 febbraio 2004
di Gian Maria Tosatti
|
|
|
|
|
Coniugazione: presente storico
Arrivo a Strasburgo nel primo pomeriggio. Una città alsaziana che pare ancora portarsi addosso le tracce di un secolo di contese. Per le strade i tassisti parlano francese e tedesco. Non c'è una gran voglia di partecipare. Gli alsaziani sembrano cani presi a calci nelle loro ridicole case ordinate. In questa terra di confine, il Parlamento Europeo è letteralmente un mostro. La sinagoga un posto particolarmente triste. E c'è anche un gran silenzio come se qualcosa fosse in attesa di cominciare. E il mostro accampato appena fuori città, con la sua figura inorganica, idea deforme, sembra già sembra già una creatura agonizzante. Uno schermo di cui rimpiangere l'illusione.
Tra questi scorci rapidi arrivo al Teatre le Maillon au Waken per la prova generale. Aspetto un po' e guardo le facce dei pochi spettatori, una quarantina. Fanno paura. Con la loro aria da giovani intellettuali borghesi, che certamente la sanno molto più lunga di me. Si può entrare.
Salgo l'imponente gradianata e riscendo fino alla settima o ottava fila. Dietro di me c'è Claudia Castellucci che scrive. Anche lei è arrivata oggi. Annota. Domani c'è il debutto.
Il palcoscenico è al buio, ma si intravede coperto da più di un metro di terra. Al centro c'è una specie di montagnola ancora più alta. La parete di fondo è alta circa dieci metri ed è completamente composta da pannelli di vetro. Le uniche luci arrivano dal parcheggio che sta oltre. Luci da illuminazione stradale. Quelle sulla platea si spengono. E io resto a guardare, oltre il palco, il parcheggio. Per due, tre minuti, con una inerziale attenzione, come si sta alla finestra di notte. Condizone voyeuristica conclamata. E' immediatamente chiaro che questo episodio dà una sterzata netta alla "Tragedia" verso una riflessione diretta sullo spettatore. Per essere più precisi il predicato della tragedia definisce la propria coniugazione riflessiva. Inizia lavorando sullo sguardo dello spettatore e gli fa guardare altri spettatori, altri spettatori che guardano. Ci mette poco, infatti, un pullman a parcheggiare davanti a noi, oltre il finestrone, e a far scendere un'allegra brigata di spettatori (ovviamente la condizione "turistica" dello spettatore è un rimando troppo facile e andrebbe ampliato sviluppandone la complessità, ma per ora ci aiuta). I passeggeri scendono e si mescolano come carte, si dividono in gruppi paiono ostili uno all'altro, ma è chiaro che tutto questo è solo un gioco di forme. Finché tutti assieme, non siedono sulle sedie di un cinema all'aperto. La proiezione incomincia. La pellicola è "Psycho" di Hitchcock. Con tanto di sigla. E, devo essere sincero, tanto di noia nel guardare dieci minuti di film in inglese laggiù, in fondo al parcheggio. Noia straniante che non mi permette mai di distrarmi dalla mia presenza (tra attiva e passiva) nervosa, sulla sedia del Teatre le Maillon au Waken.
Ad un certo punto lentamente quasi impercettibilmente, tra noi e il parcheggio si rischiara la scena. Riconosciamo qualcosa che somiglia ad un campo militare. Alcune tende verdi da cui escono figure femminili in divisa mimetica. Sono soldatesse di colore, negre, che poco a poco iniziano a muoversi nello spazio. Lavando panni, accendendo fuochi, sciacquandosi le mani e la faccia. Sembra non abbiano alcun contatto con un'ipotetica base. E sembra che non ce la facciano davvero a reggere ancora. Una di loro indossa un passa montagna e alza il pugno chiuso. Lo riabbassa. E' una visone stanca, come poco dopo, quando dissotterra una bandiera rossa che qualcuno aveva seppellito (Dove? Dove siamo? Esattamente dove sta questo deserto che abbiamo davanti agli occhi?). La sventola mentre in sottofondo in una paradossalità dalla stringente coerenza suona un canto liturgico in latino. (Ancora, dove siamo? Che ci fanno una bandiera rossa sepolta e un'eco santa-cattolica in mezzo al deserto?) La bandiera e il pugno sembrano caderle dalle mani di fronte al mezzo stupore delle sue compagne. L'unica cosa che riesce a restare in piedi è il rito sconosciuto che tutte le donne esprimono ad un tratto con un canto strutturato, una preghiera rivolta in diverse direzioni. Un rito naturale tanto quanto il pulire gli stracci e sotterrare i propri assorbenti sporchi. Gli spettatori europei, oltre il finestrone continuano a guardare lo schermo, ma il film è finito. Lo schermo è bianco. Non me ne curo. Poco dopo le luci si oscurano, la squadriglia se ne va. Una donna, per ultima tira un panno steso a terra e scopre uno scheletro umano ai piedi di un prisma.
Anche gli spettatori europei se ne vanno. Una porta si apre nel finestrone. Dal fondo del parcheggio di fronte a noi, come fosse un'allucinazione, avanza a gran velocità un carro armato. Entra nel teatro, sale sulla montagnola di terra coi suoi rumorosi cingoli e punta il suo occhio-cannone contro la gradinata. La corda è tirata al massimo e la tensione insopportabile. Verrebbe voglia di alzarsi e dire basta di maledire la compagnia, ma si resta seduti e zitti, con timore. Perché davanti a noi c'è un arma puntata che ci tiene inchiodati sulla nostra sedia come se qualcuno puntasse un'arma contro di noi.
Coniugazione: un minuto di differita.
Questo episodio riflette e si riflette nel ruolo dello spettatore che guarda e che vede (che cosa vede?) nella tragedia contemporanea, che è il bacino dell'Endogonidia. Da un minuto guardo uomini che guardano. Tra me e loro, lungo la linea tesa che si era venuta a creare s'è intromessa una nuova visione scura. Una visione di mezzo. Il punto nero centrale che fa del segmento del mio sguardo il diametro di una circonferenza. Un altro punto d'osservazione. Tra spettatori e spettatori, qui, a Strasburgo, sede del Parlamento Europeo, si interpone la zona cieca della politica internazionale. Una squadriglia femminile. Donne soldato. Donne come ventri fecondi, come matrici della discendenza, lo testimoniano i loro assorbenti sporchi di scangue che una di loro sotterra. Un commando di donne, un commando dimenticato in qualche posto (un posto con echi e sepolture familiari), come fosse privo di contatti radio da chissà quanto tempo. Un nucleo femminile come incubatrice di un popolo, come macchine della fecondità in attività disordinata. Tra loro alcuni bambini. Senza ordini e senza parole. La loro è una sequenza di gesti umanamente essenziali, fisiologici più che fisici. Ogni altro tipo di espressione (pugni chiusi o sventolare di bandiere rosse) si sviluppa e muore nel giro di poco tempo con un ciclo di disarmante naturalità, come grida lanciate senza eco che si spengono col respiro. Niente ce la fa a resistere se non la resistenza "naturale" (ripeto ancora questa parola). Continuo a chiedermi dove siamo e l'unico nome che mi viene in testa è Strasburgo. La città che sta scritta nel titolo di questo episodio. La città in cui si legifera. La città dello scripta manent. (Ma no. Ma il diritto internazionale? Non era stato... solo un anno fa? Dove siamo? Oggi? Fino ad un minuto fa mi chiedevo dove fosse sulla mappa dell'Europa il deserto in cui si muovono le figure scure e ora mi domando dove siamo noi nella mappa impossibile di quel deserto.). E non faccio in tempo a finire di seguire il filo dei miei pensieri perché dal fondo del parcheggio che ho spiato per tutto lo spettacolo arriva un carro armato a puntarmi contro il suo atterrente occhio nero.
E non era possibile che succedesse altro. In fondo è dall'inizio che i protagonisti non siamo che noi. Noi siamo il punto d'osservazione e gli osservati in un gioco circolare particolarmente scomodo, come un cerchio al collo, una specie di collare a strozzo. Ed è dal buco nero di quel cannone che l'altro punto di vista, quello che per breve tempo abbiamo visto muoversi davanti a noi in forma di figure scure in mimetica, ora osserva noi. Ma in fondo, è nostro anche lo sguardo dentro l'occhio del cannone, perché qui in fondo non ci siamo che noi. E' il nostro sguardo confessato, lo sguardo che si spinge nel caledoscopio dei nostri discorsi da intellettuali o da bar. Il nostro sguardo di cui andiamo fieri, il nostro sguardo "anti-". Anzi lo era finché l'occhio del cannone, il nostro occhio di cannone, non si è aperto fisicamente, alla lettera, davanti a noi e ha provocato tutta la paura, la "strizza", dell'altro nostro occhio, quello fisso su Psycho.
Un gioco di specchi che si moltiplica. Gli spettatori guardano finti spettatori, i quali a loro volta stanno di fronte ad un film la cui struttura è speculare rispetto allo spettacolo (?) che stiamo, hic et nunc, vedendo, ma che prima ancora (in senso cronologico rispetto alla coscienza) è una proiezione metaforica della loro (nostra) condizione di schizofrenia etica e prima ancora esistenziale. Schizofrenia nell'essere pietosi e cinici, vigliacchi e sanguinari, nell'essere Norman Bates sofferente che non riesce ad uccidere la madre assassina che è sempre in Norman Bates ed è Norman Bates. E Castellucci ci smaschera una volta di più. Ma questa volta ci inchioda catarticamente. Ci mette di fronte alla possibilità concreta di desiderare che l'occhio di cannone spari, l'occhio umano uccida fisicamente quello sociale, che l'occhio negro uccida quello europeo, che l'occhio mestruale uccida quello legiferatore. E ci siamo "cagati addosso". E nessuno avrebbe sparato quel colpo metaforico. Nessuno avrebbe sparato se non quando, una volta uscito, si fosse trovato al sicuro sul suo tram verso casa.
In questo episodio, forse più complesso, più problematico, e fors'anche più farraginoso degli altri il primo segnale che la macchina funziona. Che ci fa tornare a casa con le gambe pesanti, le gambe molli.
Appendice.
C'è stata rappresentazione? Sì, non c'è stato altro. E rappresentazione della rappresentazione. L'impianto teorico dell'Endogonidia regge. Ma a me pare che ci sia dell'altro e mi sfugge.
|
|
|
|
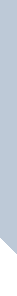 |

 L’ultimo numero di LifeGate Teatro
L’ultimo numero di LifeGate Teatro
|
Pubblichiamo oggi, 30 marzo 2005 l’ultimo numero di LifeGate Teatro, settimanale di teatro e danza che per due anni e mezzo ha compiuto la sua attività editoriale all’interno del progetto LifeGate. Sono stati mesi importanti per noi. Abbiamo cercato di cambiare il modo di fare giornalismo teatrale. Di rifondare la critica italiana cercando di capire quale fosse il suo ruolo in questo presente storico. La nostra sfida non era riuscirci. Era provarci. E forse ci abbiamo provato piuttosto bene.
On-line rimarranno gli archivi di questi due anni. Il lettore “postumo” potrà trovarvi le tracce del nostro lavoro e certamente dei contributi utili alle sue ricerche sul teatro italiano contemporaneo.
Per il numero di chiusura avevamo chiesto ai nostri lettori di scrivere qualcosa su di noi. Alcuni lo hanno fatto. E pubblichiamo i loro piccoli, ma importanti, contributi nei due articoli intitolati Bon nuit. Altri, davvero molti, hanno preferito mandarci messaggi di carattere più strettamente personale, che scegliamo di non pubblicare. Ma li ringraziamo tutti. Quelli di cui riportiamo i commenti e quelli, troppi per poterli citare, di cui conserveremo gli appelli alla resistenza, che per noi sono stimolo di trasformazione.
Per chiudere ci sembrava infine giusto puntare ancora una volta l’obiettivo su un problema centrale, quello che ha dato vita due anni e mezzo fa a questa rivista, ovvero la necessità di esigere di più dalla critica italiana. E un dovere degli artisti e noi ad essi ci rivolgiamo.
- Redazione Teatro -
|
|
| |

|
|