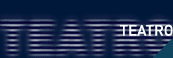 |
| |
Dialogo settimanale su teatro e danza.
ANNO 2024 NUMERO 37
Dal 13/05/2024
al 20/05/2024
Aggiornato il lunedì sera
|
|
 |
 |
 |
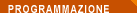 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
| Loretta strong. Eine Symphonie des Grauens
|
|
| Debutta l’ultimo lavoro di Egum Teatro che conferma il gruppo tra le più solide realtà della ricerca italiana. |
|
|
|
|
di Gian Maria Tosatti
|
|
|
|
|
Ogni volta che ascoltiamo o leggiamo qalsiasi espressione linguistica del passato, sia essa il Levitico, o il best-seller dell’anno precedente, noi traduciamo.
George Steiner.
Esco dal Supercinema di Santarcangelo, dove ha appena avuto luogo il debutto di Loretta Strong di Egum Teatro. C’è grande soddisfazione. Tutti ridono molto. Mi attardo con i critici presenti. Sento ripetere le lodi di Copì. Sento ripetere passaggi del testo indubbiamente divertenti. Sento ancora ridere e ridere come in sala. Di certo io ho visto un altro spettacolo. Mi chiedono di acconsentire al fatto che “è forte Copì”. Resto perplesso.
Nel corso del Novecento l’Ermeneutica ha prodotto diversi saggi illuminanti sul problema della “traduzione”. Sul rapporto tra un testo e il suo lettore. Sul fatto specifico che ogni volta che si legge un testo si compie un atto di ricreazione integrale. Penso al teatro e mi pare che la situazione si complichi ulteriormente perché si aggiunge un termine ennesimo al rapporto. La dinamica è pressappoco questa: l’autore scrive un testo, il regista che è a sua volta autore ne compie una prima traduzione, in fine lo spettatore opera inevitabilmente una seconda traduzione. Mi faccio questo passaggio mentalmente e mi domando istintivamente il perché si debba insistere a tornare a tutti i costi a quel primo termine dell’opera d’arte quando essa è già declinata in qualcosa di radicalmente diverso in base alle necessità del “lettore”. E me lo domando senza tener conto delle tesi di Hirsch e Gadamer, che danno per impossibile tale operazione, piuttosto mi collego al concetto di Sartre per cui “un’opera non esiste se non è ricreata dal lettore”. Se questo è vero allora la Loretta Strong che ho visto non c’entra niente con Copì. Il rapporto, al massimo è tutto tra me e Egum Teatro, unico autore di quello che è accaduto sulla scena.
Ma in fondo, senza ricorrere all’Ermeneutica, tutto questo è palese. Basta guardare lo spettacolo. L’attraversamento di Copì da parte di Egum è chiaramente pretestuale. Lo è a tal punto che la coppia di registi, Virginio Liberti e Annalisa Bianco, si permette di fare col testo tutto quello che vuole, gli cambia ritmo, registro, contesto, eppure non cambia nulla. E’ ovvio che lo spettacolo è altrove. E’ ovvio che la necessità è altrove che in Copì. Al massimo passa attraverso il canovaccio dell’autore argentino, prestato con l’umiltà che distingue le grandi opere nel “mettersi al servizio”. I critici continuano a ripetere le battute del testo e a ridacchiare. Penso: “Siamo senza speranze.” Ma c’è un lato buono, gli spettacoli di Egum hanno quella santa irriverenza che permette di ridere alle spalle dei signori critici.
Ricostruisco con calma quello che ho veduto. Leggo gli appunti che ho scarabocchiato al buio sul taccuino. Provo a venirne a capo, perché è il mio lavoro. E quello che trovo è una resa. La resa di tutto. Del linguaggio, dell’immagine. Del tempo-ritmo. La resa assoluta di ogni convenzione. Sembra quasi un atto provocatorio, come a dire: “se rompo tutto riuscirete a vedere il cuore della struttura?”. Pare che Liberti e la Bianco ci chiedano di smetterla col pensare al teatro, di cercare i rimandi e ci tirino fuori dalle macerie la domanda essenziale. La domanda che “si serve del teatro” per essere posta. In questa Loretta il punto di riflessione ruota attorno alla solitudine. Cosa accade quando si è soli.
Questo interrogativo emana dalla scena con chiarezza, rimbalza negli echi dei suoni, nelle rifrazioni televisive che entrano dalla finestra. Mentre lentamente, fin dall’inizio la parola si fa verso e pietra. Parole ciottoli che si ammassano sul palcoscenico fino a coprirlo sommando la loro massa le une alle altre. E se ne sente il peso ancorarci a terra sbattuti come siamo in platea dal turbine del terrore che agita la protagonista e i suoi cento chili in lotta con la bufera cieca della lontananza. Nel suo loculo domestico, esposta all’agguato delle proprie accumulazioni di oggetti, di fili a strozzo, di polvere, di nevrosi.
Copì l’ho già perduto da un pezzo. Dall’inizio, ovvero quando Egum ha iniziato a prenderlo alla lettera. (Prendere alla lettera significa spalancare i significati di ogni passo, rendere il procedere quasi impossibile e tenersi in sospeso tra lo sbattere e il precipitare.) Ma allora nella grandinata battente di queste parole l’autore del testo torna in eco, brillante, acuminata, indomabile eppure lontana, trascesa. Quella di Egum mi appare come un’operazione di ripolarizzazione del respiro su cui Copì mise le sue parole. Operazione del tutto legittima, che demistifica la convenzione del testo letterario non attraverso l’impatto ardente dell’eresia, quanto piuttosto col colpo gelido dell’ortodossia assoluta.
Da qui si apre un foro che ci porta altrove, appunto a domandarci dove finiscano tutte quelle parole, le parole pronunciate nella solitudine primitiva. Egum ci fa fare la prova del sassolino nel pozzo. Ci fa ascoltare il suono dell’abisso o la sua parvenza. Ci fa cercare dentro di noi il perimetro del crepaccio in cui precipitiamo quando siamo soli.
Ancora osservo il tempo in cui mi cala Egum. Il tempo fatto di isole morte. Senza incursioni trainanti. Un tempo privo della consequenzialità lineare: è un tempo a due direzioni su un diametro orizzontale, al centro delle possibili curve di un destino che non si lascia calcolare. In questa sospensione che richiama gli effetti di Quarett mi pare di riconoscere quella sapienza teatrale che permette allo spettatore la possibilità di restare a distanza. A guardare.
Intanto le trappole vengono smontate una a una. Il ritmo sale vertiginosamente, ma non cambia niente. I contrappunti sono abbattuti, al testo è data una nuova sintassi. Cosa ne resta? Il suono delle parole. Ma quello è già diventato musica e non lo avverto più se non mescolato al lamentarsi molle di tutti quegli oggetto accumulati sulla scena, muti sì, ma ognuno ad urlare il proprio scricchiolio, fruscio, trillio, potenziale è vero, ma in agguato. Per cui una parola invece che un'altra non fa la differenza. Un tuono neppure, un movimento, un tempo. Nulla. Quelle della solitudine sono pareti su cui non si attacca nulla. Pareti che moltiplicano gli echi fino alla saturazione, al sovraccarico. Echi che ripetono ossessivamente “Basta!” fino ad una chiusura che arriva improvvisa, come un infarto. Senza climax, senza niente. Di botto. Non perché sia finito, ma perché, basta, non c’è più niente da vedere. Si sono stancati di lasciarci guardare. Va bene così.
|
|
|
|
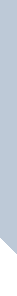 |

 L’ultimo numero di LifeGate Teatro
L’ultimo numero di LifeGate Teatro
|
Pubblichiamo oggi, 30 marzo 2005 l’ultimo numero di LifeGate Teatro, settimanale di teatro e danza che per due anni e mezzo ha compiuto la sua attività editoriale all’interno del progetto LifeGate. Sono stati mesi importanti per noi. Abbiamo cercato di cambiare il modo di fare giornalismo teatrale. Di rifondare la critica italiana cercando di capire quale fosse il suo ruolo in questo presente storico. La nostra sfida non era riuscirci. Era provarci. E forse ci abbiamo provato piuttosto bene.
On-line rimarranno gli archivi di questi due anni. Il lettore “postumo” potrà trovarvi le tracce del nostro lavoro e certamente dei contributi utili alle sue ricerche sul teatro italiano contemporaneo.
Per il numero di chiusura avevamo chiesto ai nostri lettori di scrivere qualcosa su di noi. Alcuni lo hanno fatto. E pubblichiamo i loro piccoli, ma importanti, contributi nei due articoli intitolati Bon nuit. Altri, davvero molti, hanno preferito mandarci messaggi di carattere più strettamente personale, che scegliamo di non pubblicare. Ma li ringraziamo tutti. Quelli di cui riportiamo i commenti e quelli, troppi per poterli citare, di cui conserveremo gli appelli alla resistenza, che per noi sono stimolo di trasformazione.
Per chiudere ci sembrava infine giusto puntare ancora una volta l’obiettivo su un problema centrale, quello che ha dato vita due anni e mezzo fa a questa rivista, ovvero la necessità di esigere di più dalla critica italiana. E un dovere degli artisti e noi ad essi ci rivolgiamo.
- Redazione Teatro -
|
|
| |

|
|