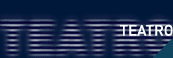 |
| |
Dialogo settimanale su teatro e danza.
ANNO 2024 NUMERO 37
Dal 13/05/2024
al 20/05/2024
Aggiornato il lunedì sera
|
|
 |
 |
 |
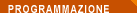 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
| Il senso dello sguardo |
|
| Conversazione (anche) sulla critica con Pippo Delbono. |
|
|
|
|
di Pippo Delbono e Gian Maria Tosatti
|
|
|
|
|
Ultimamente hai preso posizione contro la critica. Non tanto contro le persone che la rappresentano, perché sarebbe riduttivo. Ma rispetto all'espressione della critica in Italia. Condivido a pieno. Perché, a prescindere dal fatto che sia cattiva o meno, credo inutile la critica che si fa e che si legge oggi in Italia. Manca la volontà di dialogo con gli artisti e col pubblico.
Il problema della critica mi pare sia il non rispondere ad una missione chiara. E credo che a definire la missione debbano essere i referenti di questo "ufficio" che è per definizione speculare. Così voglio aprire questa conversazione domandandoti quale potrebbe essere l'importanza della critica per gli artisti?
Una figura critica che con umiltà, uscendo dai vincoli del proprio io, facesse un viaggio insieme ad una compagnia sarebbe molto importante. Perché arriva un momento nel processo di uno spettacolo, in cui un artista, che è anche attore, come me, per esempio, deve abbandonare la "lettura" per trovare una dimensione innocente all'interno del lavoro. Sarebbe importante se, allora, chi guarda lo spettacolo professionalmente, e il cui lavoro compete l'intelletto e non il corpo, si occupasse di cogliere qualcosa che tu hai intuito, ma non hai voluto scrivere. Di intraprendere quella riflessione che non traduce il lo spettacolo, ma parte dallo spettacolo. Una volta che questo è finito. Cioè quando è arrivato il momento di consegnarlo allo sguardo degli altri. Quando senti che tutte le tensioni che hai messo all'interno hanno raggiunto un equilibrio. Quello è anche il momento di consegnare l'eredità dello sguardo critico a qualcun altro che dovrebbe iniziare a cercare.
Quello che mi dici mi restituisce un'immagine della critica come "studium". E se mi lasci dire mi pare che oggi quest'impostazione sia piuttosto rara. Perché quando un critico non descrive ciò che ha visto, al massimo cerca di tradurlo in parafrasi o di giudicarlo.
Il problema è appunto questo. Vedi, uno spettacolo è un fenomeno e come tale va studiato. Non è accettabile lo sguardo distratto. L'approccio di una serata. Non ha senso. Bisogna capire che cosa sta succedendo. Domandarsi chi siano le persone che compiono quella determinata esperienza. Forse uno spettacolo va visto molte volte per poter veramente assumersi la responsabilità di parlarne. Prima bisogna cercare di capire Bobò, chiedersi chi sia, e il perché quest'uomo sia così intensamente espressivo in ogni gesto. E poi chiedesi perché un determinato spettacolo sta girando il mondo. Cosa gli succede attorno. Avere attenzione per l'evento e per la sua circostanza. Questo per una critica che sia analitica. Ma c'è un altro tipo di sguardo che manca e che per me è determinante. Cioè quello della semplicità. Dell'interesse per ciò che non è stato capito. A Parigi per esempio, Colette Godard, una signora che ha fatto la storia della critica francese, mi ha detto che arriva un momento nei miei spettacoli in cui si commuove e non sa il perché. E' da qui che comincia il suo interesse. E da qui parte e si sviluppa la sua riflessione.
In Italia sembrerebbe un'eresia. Se ci fai caso sembra che qui si capisca tutto.
Ma non sarebbe nemmeno tanto grave se poi non ti rendessi conto che gli elementi attraverso i quali un critico capisce il tuo spettacolo dipendono dalle sue piccole beghe, gelosie o magari dal fatto che se sei amico di un certo critico vedrai che qualcun altro darà più peso a questo che allo spettacolo.
Il problema per molti artisti credo sia superare questo clima di paralisi della comprensione. Che poi è anche una paralisi della curiosità...
E' forse il consenso che ti libera dal rapporto mortifero che stabilisci con questi osservatori che hanno il potere di illuderti che non esisti se loro non ti vedono. Quando il tuo lavoro diventa un'esperienza di massa è come se riazzerassi i livelli in sala. E le voci valgono tutte allo stesso modo. Per cui il valore sta in cosa si dice e non in chi lo dice. Il critico diventa chi con umiltà inizia a farsi domande su quello che ha visto e te le pone. Diventa la persona in cui ravvisi saggezza e che parla dello spettacolo nel bene o nel male, ma con volonta di costruire. Allora va bene anche la violenza. Perché gli schiaffi sono importanti, ma vuoi che arrivino da persone sagge.
Ma quando è che si diventa saggi?
Quando hai molta cultura, ma è una cultura di vita non una cultura di testi che si hanno sulla scrivania. Quando diventi vecchio e ti avvicini alla morte. Quando hai capito che il tuo io non è poi così importante. Quando non sei più permaloso. Diventi saggio quando vai oltre il tuo giudizio, cioè quando sei in grado di stabilire un rapporto di altruismo. Invece a me pare che gli ambienti della cultura si siano imborghesiti al punto di credere che se si hanno le idee giuste si pensa correttamente. Oppure che si debba far cerchio attorno alla cultura sfiorando situazioni paradossali. Pensa all'idea del consenso per come l'ho messa prima. Il fatto che ai miei spettacoli vengano millecinquecento persone a sera è qualcosa che non va giù. Perché chi opera nella cultura avrebbe preferito che tu avessi continuato a fare spettacoli nelle cantine e che solo lui poteva scoprirti. Se il tuo lavoro inizia ad avere masse di pubblico allora è come se sfuggi al controllo. E tutto questo per me è indice di grande confusione. E lo vedi anche nel modo di portare in alto certi giovani che si improvvisano attori o registi. E' qualcosa che ha a che fare col potere. Col consolidamento del potere.
Infatti ai "fenomeni" di questi anni credo sia stata appunto negata l'originalità. Ai nuovi giovani emergenti non sono state fatte domande in merito a cosa stanno realizzando e dunque a chi sono e cosa sono. Domande che mettono in crisi, che spingono verso la consapevolezza di certe scelte. Che forse mettono a ferro e fuoco i processi di lavoro, ma che anche possono rivelare dei valori nuovi. Mi sembra che invece qualcuno abbia riconosciuto in qualcun altro dei valori già condivisi e dunque abbia dato la propria benedizione a quei valori, trattando questi artisti né più e né meno che come feticci delle proprie idee...
In questo modo il teatro muore e anzi è già morto da tempo. Senza prenderci in giro, se proviamo a guardarlo lucidamente ci rendiamo conto che oggi è il prodotto di una borghesia culturale. E te ne rendi conto guardando chi ci va a teatro. Sono sempre gli stessi. E i giovani non ci vanno. Non gli interessa più. Ed è perché dentro non ci trovano niente di "reale" o niente da condividere. Te l'ho detto. Uno dei risultati più importanti del mio lavoro è che vengono a vedermi persone che in teatro non vanno mai.
Ma quello del teatro è un problema conseguente ad altri problemi. L'imborghesimento del pensiero e dunque il suo allontanarsi dalla vita non dipende dal teatro o da chi lavora nel teatro, fossero i critici, a cui stiamo dando anche troppa importanza, o gli artisti. Ma ciò condiziona fortemente il teatro rendendolo il luogo in cui si "rappresenta" un modo che non esiste. Che è distante anni luce dalla vita vera. Lo vedi dal fatto che il teatro non è accettato come un'esperienza popolare. Perché ciò farebbe sentire il professore o il critico allo stesso livello della verduraia. Ma in realtà è alle verduraie che devi rivolgerti se vuoi riappropriarti del ruolo sociale del teatro. Altrimenti ti sta bene che le masse vengano nutrite con quella televisione che poi critichi. Perché il teatro è lo spazio delle verduraie. E' nei luoghi in cui vivono le verduraie. Io ho trovato il teatro ovunque, nella strada, nella musica, negli ospedali, nel manicomio, nel dolore, nella malattia, nella follia. E solo un pochino nei testi o in tutti gli orpelli dell'arte drammatica.
Mi pare di aver scritto tempo fa che il punto di collasso del pensiero sul teatro sia il volerlo ricondurre a tutti i costi al teatro stesso...
E' esatto. Invece io credo che il teatro sia un'esperienza complessa. Che uno spettacolo sia un'esperienza del fuori, di quello che c'è dietro. Della vita. Altrimenti quello che noi facciamo sarebbe estremamente debole. Nelle tournée mi sono fatto l'idea che in paesi come il Brasile c'è più capacità di capire il teatro. Perché su chi vive in certi paesi l'urgenza della vita con le sue contraddizioni è potente. E' reale. Qui è incredibile sentire che se costruisci un'immagine o usi un testo forte, scioccante, come urlare "L'Aids è santo", vieni accusato di furbizia, di voler attrarre il pubblico. Ma questo non è vero. Questa malizia non è nell'artista, ma in chi guarda. Perché se la vita l'hai toccata ti rendi conto che se anche sei in prigione, se sei stato rapito da qualcuno, puoi anche ridere. Se la vita l'hai toccata veramente nelle zone profonde sai che ci sono contraddizioni profonde. Allora sei saggio e sei banale, sei brigatista ma ti piace Mina, sei marxista ma pensi che forse Dio esiste.
Mi pare che una volta per tutte tu metta il punto sul fatto che il teatro sia un'esperienza di vita (per chi lo fa e per chi vi assiste), e non la "rappresentazione" della vita. Ma qual è il problema perché ciò venga capito sulla pelle?
E' lo sguardo il problema. Mettiamola così. Ci sono due differenti "io" nell'uomo. Quello grande risponde alla parte più profonda si sé stessi. Quello piccolo risponde all'autoreferenzialità verso se stessi. In ogni esperienza che fai devi scegliere attraverso quale "io" procederà il tuo sguardo. Dunque la differenza sta, nella possibilità di attraversare qualcosa, anche uno spettacolo, come un'esperienza profonda di conoscenza di sé. Sarà così se il tuo è uno sguardo semplice. Se diventi curioso, se apri gli occhi quando ti succede qualcosa. Senza l'ottenebrante desiderio di aver capito.
|
|
|
|
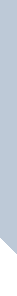 |

 L’ultimo numero di LifeGate Teatro
L’ultimo numero di LifeGate Teatro
|
Pubblichiamo oggi, 30 marzo 2005 l’ultimo numero di LifeGate Teatro, settimanale di teatro e danza che per due anni e mezzo ha compiuto la sua attività editoriale all’interno del progetto LifeGate. Sono stati mesi importanti per noi. Abbiamo cercato di cambiare il modo di fare giornalismo teatrale. Di rifondare la critica italiana cercando di capire quale fosse il suo ruolo in questo presente storico. La nostra sfida non era riuscirci. Era provarci. E forse ci abbiamo provato piuttosto bene.
On-line rimarranno gli archivi di questi due anni. Il lettore “postumo” potrà trovarvi le tracce del nostro lavoro e certamente dei contributi utili alle sue ricerche sul teatro italiano contemporaneo.
Per il numero di chiusura avevamo chiesto ai nostri lettori di scrivere qualcosa su di noi. Alcuni lo hanno fatto. E pubblichiamo i loro piccoli, ma importanti, contributi nei due articoli intitolati Bon nuit. Altri, davvero molti, hanno preferito mandarci messaggi di carattere più strettamente personale, che scegliamo di non pubblicare. Ma li ringraziamo tutti. Quelli di cui riportiamo i commenti e quelli, troppi per poterli citare, di cui conserveremo gli appelli alla resistenza, che per noi sono stimolo di trasformazione.
Per chiudere ci sembrava infine giusto puntare ancora una volta l’obiettivo su un problema centrale, quello che ha dato vita due anni e mezzo fa a questa rivista, ovvero la necessità di esigere di più dalla critica italiana. E un dovere degli artisti e noi ad essi ci rivolgiamo.
- Redazione Teatro -
|
|
| |

|
|