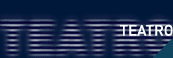 |
| |
Dialogo settimanale su teatro e danza.
ANNO 2024 NUMERO 37
Dal 13/05/2024
al 20/05/2024
Aggiornato il lunedì sera
|
|
 |
 |
 |
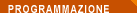 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
| Urlo: reazioni |
|
| Appunti su Urlo, ultimo spettacolo di Pippo Delbono |
|
|
|
|
di Gian Maria Tosatti
|
|
|
|
|
ROMA (Teatro Argentina) - Credo che il dono… Credo che il dono di uno spettacolo, sia condurre per strade familiari rivelandole diverse. Credo che il dono sia ferire l’innocenza dello spettatore. Che sia l’epifania. E credo che il dono di Pippo Delbono sia la capacità di ferire l’innocenza con l’innocenza (ancora un pensiero alla sua Sarah Kane).
Personalmente ho scalato per decine di volte i versi di Allen Ginsberg, precipitando ogni volta nella genesi di quel primo verso: “Ho visto le menti migliori della mia generazione”. Ho calpestato quelle parole tutte le volte e sono state ogni volta il battesimo della scalata. Il battesimo del fallimento. Non sono mai riuscito ad indossare il suo Urlo come un guanto. Talvolta sì, come un paramento sacro, mai come un guanto…
Poi dal niente, dal buio della platea viene fuori, col suo passo barcollante Delbono. Un completo scuro e scarpe da ginnastica bianche. Una visione improbabile. Arriva e ricomincia il verso. “Ho visto le menti migliori della mia generazione…” . Eccoci. E le mie palpebre ferite, spalancate. Mi domando di che generazione stia parlando. E la domanda si sa, è un agente chimico… Mi domando… E le parole si scaricano del peso della loro storia. Il verso si nega alla contestualità della pagina fino alla purezza del dire (e non del “detto”). Fino alla necessità del fiato. “Ho visto le menti migliori dell mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate nude isteriche…”.
Sillaba dopo sillaba, pronunciate con calma snervante, con calma instabile. Urlo diventava il tempo presente di quelle parole. Urlo era il trovarsi facci a faccia con qualcuno che non recita ma parla, dicendo. Con l’urgenza del presente. Con la parola come azione e non come metafora. Come dire: “al fuoco!”.
Urlo allora non è il titolo di uno spettacolo. Ne è piuttosto la definizione sintetica. Urlo è ogni nota di questo ultimo lavoro di Delbono, detonazione strabordante, distante dal rigore drammaturgico di Gente di Plastica, con la sua calcolata schiettezza. Urlo è un moto di passione, che non si capisce nei dettagli. Si perdono le parole. Ma resta l’impressione di un uomo in mezzo alla folla, che ad un tratto, violenta il paesaggio marziale (vengono in mente le descrizioni newyorkesi di Céline) con un urlo.
Un urlo, di sorpresa, in mezzo alla folla che accende l’animale istinto di sopravvivenza. Attiva le allerte. Abbatte la fordiana catena di montaggio dei pensieri.
Pochi i testi. E le immagini rimandano altrove. Urlo prima di tutto non è uno spettacolo. Non c’è rappresentazione in nessun modo (se non la recita della rappresentazione). E’ un evento di per sé significante (l’unico teatro che oggi abbia senso, indipendentemente dall’estetica o dalla tradizione di riferimento). E che perciò non può e forse non deve essere scomposto e analizzato nei suoi dettagli. La sua forza sta nell’atto politico di esserci. Di venire prodotto di fronte ad un’assemblea di esseri umani. Ed è prodotto ad arte, è vero. In una sequenza disordinata (ma proprio per questo perfetta) di immagini scioccanti. In una progressione di sovraccarichi uditivi e visivi in cui si finisce per non distinguere più nulla, fino alla sordità e al senso di solitudine nel silenzio traumatico e artificiale che segue la detonazione. Si resta inebetiti in overload acustico. Attorno, tutto suona, grida, corre. Davanti ai nostri occhi, più fissi. Si susseguono senza un ordine ricostruibile le immagini della catastrofe. Tra i quadri titanici si può isolare un volto. Una smorfia. Ed è tutto lì. Nel catturare quella smorfia dentro al silenzio che ha seguito l’urlo.
Poi lentamente i suoni si disopacizzano. Di nuovo Umberto Orsini, presenza fondamentale in questo lavoro, ci rende gli ultimi, stranianti versi di Wilde, e fugge via con Bobò a sbranare un pallone con la sua fame di cane.
Tra le baracche in scena sembra essere scesa la pioggia, sul fondo un tramonto iperbolico (che forse non c’era), e il ritorno della banda che dà la sensazione della lama estratta finalmente dalle carni. Lo spettacolo è finito. La ferita non è sanata.
|
|
|
|
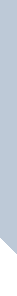 |

 L’ultimo numero di LifeGate Teatro
L’ultimo numero di LifeGate Teatro
|
Pubblichiamo oggi, 30 marzo 2005 l’ultimo numero di LifeGate Teatro, settimanale di teatro e danza che per due anni e mezzo ha compiuto la sua attività editoriale all’interno del progetto LifeGate. Sono stati mesi importanti per noi. Abbiamo cercato di cambiare il modo di fare giornalismo teatrale. Di rifondare la critica italiana cercando di capire quale fosse il suo ruolo in questo presente storico. La nostra sfida non era riuscirci. Era provarci. E forse ci abbiamo provato piuttosto bene.
On-line rimarranno gli archivi di questi due anni. Il lettore “postumo” potrà trovarvi le tracce del nostro lavoro e certamente dei contributi utili alle sue ricerche sul teatro italiano contemporaneo.
Per il numero di chiusura avevamo chiesto ai nostri lettori di scrivere qualcosa su di noi. Alcuni lo hanno fatto. E pubblichiamo i loro piccoli, ma importanti, contributi nei due articoli intitolati Bon nuit. Altri, davvero molti, hanno preferito mandarci messaggi di carattere più strettamente personale, che scegliamo di non pubblicare. Ma li ringraziamo tutti. Quelli di cui riportiamo i commenti e quelli, troppi per poterli citare, di cui conserveremo gli appelli alla resistenza, che per noi sono stimolo di trasformazione.
Per chiudere ci sembrava infine giusto puntare ancora una volta l’obiettivo su un problema centrale, quello che ha dato vita due anni e mezzo fa a questa rivista, ovvero la necessità di esigere di più dalla critica italiana. E un dovere degli artisti e noi ad essi ci rivolgiamo.
- Redazione Teatro -
|
|
| |

|
|