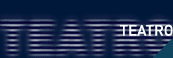 |
| |
Dialogo settimanale su teatro e danza.
ANNO 2024 NUMERO 37
Dal 13/05/2024
al 20/05/2024
Aggiornato il lunedì sera
|
|
 |
 |
 |
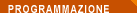 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
| Il tempo per pensare. |
|
| Dopo due anni di ricerche si dimostra la superficialità il motivo dei gravi passi falsi di Corsetti nelle sue Metamorfosi. |
|
|
|
|
di Gian Maria Tosatti
|
|
|
|
|
Mi scuso con i lettori per la prolissità di questa recensione, ma data la rilevanza dell'evento preso in esame e le reazioni che esso ha suscitato è sembrata cosa giusta dover essere più completi e specifici possibile. Si parlerà dunque delle Metamorfosi, da Ovidio, coproduzione internazionale di grandissima portata frutto di due anni di ricerca sotto la guida del regista Giorgio Barberio Corsetti, che con questo spettacolo mette il sigillo su un triennio di direzione alla Biennale di Venezia di cui vanno riconosciuti i meriti.
Purtroppo chi scrive non ha potuto assistere al debutto veneziano della performance e vi si è imbattuto solo pochi giorni dopo a Roma, dove chiaramente certe suggestioni, spostate dall'Arsenale della laguna al comunque suggestivo Parco Archeologico degli Acquedotti, potrebbero aver cambiato carattere, pagando un qualche scotto alle adattabilità forzate che si fanno e si faranno necessarie per una tournée che s'annuncia lunga.
Tuttavia non credo che i problemi principali di questo lavoro siano dovuti a tali difficoltà. Le due sezioni all'aperto, infatti, sembrano le più riuscite, più leggere, dinamiche e ricche di fascinazioni derivate dalla meraviglia di un certo manierismo umoristico che nel bosco, luogo di visioni e di allucinazioni, trova il suo spazio naturale.
Cominciando comunque dall'inizio è necessario dire che lo spettacolo, frutto di due anni di ricerca racconta le Metamorfosi ovidiane avvicinandosi particolarmente alle sensuali relazioni tra uomo e divino.
Detto questo, credo di poter iniziare l'analisi dell'opera partendo da un quadro ampio e andando a stringere progressivamente sui particolari. In questa prospettiva il primo campo d'indagine che ci si presenta è sicuramente quello legato all'impianto, inteso come cornice drammaturgica, che lega gli episodi, molto ben divisi (e direi meglio delimitati) in storie che non sviluppano nella sollecitazione di vicinanze fisiche imposte dalla scena un diverso grado di relazione rispetto a quello dimostrato nella pagina. Ciò immediatamente ci sembra essere un indice di come la lettura teatrale, che lavora su diversi rapporti di fruizione rispetto a quelli letterari, non abbia lavorato in questo progetto firmato da Corsetti in modo da poter "adattare" la "poesia scritta" verso una trasmissione che per sua definizione (o per lo meno certamente in questo spettacolo) non permette altra lettura che quella legata ad un unico possibile flusso narrativo dalle modalità predeterminate di esaurimento.
Il primo segnale ci giunge dal ricorso ad un esile filo conduttore che di fatto non riesce a cucire una vera cornice capace di ordinare uno sviluppo strutturale.
L'occasione narrativa cui questo filo avrebbe dovuto obbedire appare sicuramente più mancata che non voluta, e ne è la prova il fatto che quel filo esista nella figura di Orfeo, che tuttavia galleggia nella deriva delle storie ad oltranza come una presenza-spettro, visibile, come appunto un fantasma, solo a chi voglia proprio vederlo.
Le storie, che mi permetto di notare essere state ridotte a "storielle" con l'introduzione di un verbosissimo corifeo esplicante logica d'azione e senso degli accidenti in una poco più che improvvisata tecnica narrativa (che comunque laddove tocca i suoi vertici non supera i livelli elementari per la giustificatissima ed evidente estraneità alla specifica materia degli attori impiegati), sembrano non obbedire dunque ad alcuna legge di evoluzione strutturale interna all'impianto. Questo porta a supporre che nulla di sostanziale cambierebbe nell'intera operazione se una storia venisse tolta, sostituita od aggiunta. La cosa di per sé non può dirsi propriamente un difetto, ma fa pensare sulla profondità del progetto registico. In aggiunta mi permetto di citare l'esempio di quel sano che messagli in mano una stampella inizi a zoppicare. Questo è ciò che figuratamene avviene a causa del ricorso al succitato corifeo, che divenendo spina dorsale della struttura dei singoli episodi fa sì che questi, per ciò che concerne l'azione degli attori, non si mostrino che pantomime speculari di quanto si può udire ad occhi chiusi. (E pensare che mi sorpresi lì per lì quando seppi che uno spettacolo di circo avrebbe avuto la diretta radiofonica della "nuova" Radio 3!).
Evitando la brusca risoluzione per cui: "i doppioni sono superflui" (legge tuttavia validissima e vecchia quanto le figurine Panini), indugerei ancora sulla figura del corifeo, per farmi scoprire un altro fianco debole dello spettacolo. Esso infatti mi permette di iniziare ad analizzare i rapporti che l'opera intesse con lo spazio di rappresentazione e coi linguaggi ad esso propri. Andando per ordine mi preme riprendere la grave affermazione fatta sulla elementare tecnica narrativa del corifeo (che nello spettacolo assume diversi volti) correggendo di poco il tiro in favore di una maggiore esattezza. La figura cui mi riferisco infatti è elementare, in primis perché rappresenta la più facile risoluzione per informare su un evento che in realtà vorremmo vedere in azione sulla pista (o palcoscenico), luogo elettivo dell'hic et nunc, e in secondo luogo il corifeo racconta le sue "favolette" così come lo si farebbe in mille altri spazi dimostrando di non aver sviluppato una proprietà di affabulazione che sia armonicamente e logicamente compatibile con le possibilità che in questo campo la storia del Circo nei suoi personaggi e tradizioni sembra negli anni aver espresso abbondantemente. (In sintesi: a Corsetti non rimaneva che l'imbarazzo della scelta, ma poi ha optato per il modello base).
Detto questo possiamo iniziare ad allargare la prospettiva sul rapporto sviluppato con i mezzi espressivi e spaziali, in una parola con il Circo. Ma in realtà c'è ben poco da dire visto che questo rapporto sembra non esserci affatto. E qui mi permetto di arrischiare un'affermazione categorica perché la credo sinceramente inobiettabile, anche in ragione degli "aggravanti" sussistenti nei due anni di ricerca sul tema, che per altro hanno prodotto una ottima fioritura artistica del fenomeno in Italia attraverso il canale della Biennale. Non posso qui porre alla scena obiezioni di tipo tecnico nell'impossibilità d'individuare il campo di analisi. Infatti non credo che basti l'adozione pretestuosa di uno chapiteau perché si possa parlare di Circo, anche se tra gli attori figurano acrobati che a volte danno prova di qualche loro abilità. Vorrei chiarire che non c'è alcuna posizione di principio che mi porti a questa effettivamente dura posizione, ma il vedere che gli elementi virtuosistici della pista vengano appiccicati sulla superficie della drammaturgia sistematicamente senza che se ne senta la necessità, né spettacolare né logica, non mi permette di essere più indulgente. Che spostarsi dal punto A al punto B tramite un trapezio o le proprie gambe, quando i presupposti a questa mossa e le sue conseguenze restino esattamente le stesse e non abbiano alcun riscontro nell'apertura di una dimensione di approfondimento di un dato carattere descritto da Ovidio non dimostra nessuna relazione con il Circo, nouveau o vecchio che lo si intenda. Fili e funamboli, trapezi e trapezisti, non sono minimamente iscritti in quanto tali nella drammaturgia, e sfido chiunque ad accorgersi della mancanza di quelle attitudini se soltanto nella replica di domani venissero omesse.
La superficialità di questi innesti (ad esempio un filo sotto i piedi di Diana), e mi riferisco a quando le tecniche circensi non siano solo relegate allo sfondo, non riesce inoltre mai ad inserirsi nella vena mitopoietica ovidiana, per aggiungere un dato particolare, a causa della sua imbarazzante mancanza di giustificazioni analitiche riferite al mito stesso. (In sintesi: quando si crea un'immagine se non si è dei principianti è necessario motivarla e mostrarne la patente di categoria).
Concluderei il discorso sullo spazio con una osservazione riguardo l'uso dello stesso come deposito per una macchineria inerte di cui ci si ricorda solo di tanto in tanto (e assai di rado) e che resta esanime (avendo già finito di agonizzare tempo addietro, ovvero durante le prove) per tutto il resto del lungo spettacolo, inutilizzata e dunque inutile, senza che venga mai realmente (al pari di chapiteau e attrezzi circensi) inserita in una organica drammaturgia della scena.
Che questi difetti siano alleviati nella prima parte dal raggiungimento di una maggiore coerenza strutturale degli episodi e che invece diventino assai più gravi nel secondo tempo (per intenderci quello sotto il tendone), quando l'esile equilibrio precedentemente costituito viene polverizzato dal caos di una tessitura a maglie larghe e calanti, poco importa allora, ma quello che ci sembra possibile rilevare da uno sguardo d'insieme è la mancanza di un vero corpo performativo. Lo spettacolo diviene così paragonabile alla sagoma di un uomo che sia stato svuotato del suo scheletro e dei suoi organi interni. Esso sì agisce nell'immaginario come sembianza, ma basta poco per accorgersi che manca di un organismo.
La situazione cambia solo di rado ed esattamente, se non fosse per certi lampi di Filippo Timi, in un solo momento, quando cioè l'organismo di un attore si sostituisce a quello mancante dello spettacolo. Avviene nella scena di Vulcano, ad opera di un Antoine Rigot capace di liberare la voce della propria fisicità menomata in una simbiosi perfetta ed impressionante tra azione e rappresentazione, dandoci per un istante la cifra di cosa s'intenda esattamente per "super-tecnica".
L'ingresso di Rigot nel discorso mi solleva piacevolmente per un attimo dal mio ruolo di "medico legale" permettendomi di respirare un poco nel discorso relativo agli attori. Elogio va alla loro prova, capace di reggere un testo (forse eccessivamente parlato) che necessita di una grande propensione al sacrificio per poter essere trasformato in parola-azione. E una straordinaria nota di merito va al lavoro, peraltro ricchissimo di interessanti spunti potenziali, mostrato da Filippo Timi, che è quanto di buono si vede per tutto lo spettacolo. Timi partorisce una performance personale di estremo spessore e ai limiti dell'inappuntabile, che pare una conferma per il serio e valido lavoro tecnico sviluppato in questi anni.
Prima di passare al finale un ultima nota mi preme di specificare. L'inesorabile ripetitività del montaggio portata avanti per quasi tre ore raggiunge il solo risultato di tradursi nella creazione spropositata di tempi morti e nell'affossamento (mi si perdoni l'espressione forte) del ritmo. E crediamo che la musica abbia seguito la stessa monotonia non cercando neppure una volta di entrare in maniera attiva all'interno dell'impianto.
Ed eccoci in fine a qualcosa che invece inverte la tendenza. Stiamo parlando della scena finale, in cui tutti gli elementi sembrano rispondere ad una logica organica della scena e tutte le immagini sembrano giustificate e motivate nel loro sovrapporre l'identità del poeta Orfeo con quella certamente in certi aspetti analogica di Pasolini. Vediamo allora la doppia figura caricare in macchina un ragazzo di vita per poi raggiungere il luogo in cui verrà ucciso.
Una versione "metamorfica" di quella storia come a tutti noi piacerebbe credere si sia svolta, col poeta smembrato dalle menadi tracie per il pregiudizio della sua misoginia. Ma purtroppo tirare in ballo la morte del poeta corsaro anestetizzandone liricamente il grido di dolore che feroce da essa si leva, appare un'azione grave nel momento in cui, vagheggiando un alone romantico sulle motivazioni di quel delitto, sposta l'obbiettivo dalle domande dirette, gravi e precise che esso suscita.
Questo ennesimo atto di superficialità nei confronti di un tema-evento tanto condizionante per la cupa storia contemporanea del nostro Paese credo possa bastare per concludere un'analisi che ha fatto di tutto, seppure nella gravità dei concetti espressi, per mantenersi onesta a vantaggio dei suoi lettori.
|
|
|
|
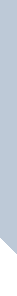 |

 L’ultimo numero di LifeGate Teatro
L’ultimo numero di LifeGate Teatro
|
Pubblichiamo oggi, 30 marzo 2005 l’ultimo numero di LifeGate Teatro, settimanale di teatro e danza che per due anni e mezzo ha compiuto la sua attività editoriale all’interno del progetto LifeGate. Sono stati mesi importanti per noi. Abbiamo cercato di cambiare il modo di fare giornalismo teatrale. Di rifondare la critica italiana cercando di capire quale fosse il suo ruolo in questo presente storico. La nostra sfida non era riuscirci. Era provarci. E forse ci abbiamo provato piuttosto bene.
On-line rimarranno gli archivi di questi due anni. Il lettore “postumo” potrà trovarvi le tracce del nostro lavoro e certamente dei contributi utili alle sue ricerche sul teatro italiano contemporaneo.
Per il numero di chiusura avevamo chiesto ai nostri lettori di scrivere qualcosa su di noi. Alcuni lo hanno fatto. E pubblichiamo i loro piccoli, ma importanti, contributi nei due articoli intitolati Bon nuit. Altri, davvero molti, hanno preferito mandarci messaggi di carattere più strettamente personale, che scegliamo di non pubblicare. Ma li ringraziamo tutti. Quelli di cui riportiamo i commenti e quelli, troppi per poterli citare, di cui conserveremo gli appelli alla resistenza, che per noi sono stimolo di trasformazione.
Per chiudere ci sembrava infine giusto puntare ancora una volta l’obiettivo su un problema centrale, quello che ha dato vita due anni e mezzo fa a questa rivista, ovvero la necessità di esigere di più dalla critica italiana. E un dovere degli artisti e noi ad essi ci rivolgiamo.
- Redazione Teatro -
|
|
| |

|
|