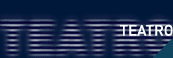 |
| |
Dialogo settimanale su teatro e danza.
ANNO 2026 NUMERO 25
Dal 23/02/2026
al 02/03/2026
Aggiornato il lunedì sera
|
|
 |
 |
 |
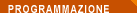 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
| Leggerezza e pesantezza nella città analoga di Martone |
|
| L’opera segreta, uno spettacolo incompiuto tra bellezza visionaria e distrazioni naturalistiche. |
|
|
|
|
di Gian Maria Tosatti
|
|
|
|
|
Perché il III e IV Granili non è solo ciò che si può chiamare una temporanea sistemazione di senzatetto, ma piuttosto la dimostrazione, in termini clinici e giuridici, della caduta di una razza.
A.M. Ortese – La città immaginaria
Inizia con una proiezione. Caravaggio, l’ultimo tempo. I vicoli di Napoli, i volti, si confondono con i personaggi sofferti e sofferenti delle tele di Michelangelo Merisi. La voce di Danio Manfredini, fuoricampo scivola rapida sulle immagini portando i testi di Anna Maria Ortese rielaborati da Enzo Moscato. Si fatica un po’ ad entrare nello spirito di quello che si vede e forse non ci si entra mai. Lo si nota all’inizio con un po’ di disappunto. Ma si capisce infine che questa fragilità, questa incalcolatezza di pesi e sbilanciamento sarà un carattere ricorrente di quest’opera e della sua incompiutezza. Il video denuncia un limite fondamentale nella gestione dell’equilibrio tra il pieno dell’immagine in continuo movimento, scalando strade o corridoi, arrampicandosi sui piani dei palazzi o sulle alture che assediano il golfo, e il pieno della parola, poetica, a sua volta tesa in una dinamica impegnativa, che non mi dà respiro.
La proiezione termina ed ha inizio il corpo centrale di questo spettacolo, l’episodio da cui esso prende il titolo: L’opera segreta.
L’universo poetico è ancora quello della Ortese e del suo Il mare non bagna Napoli, di cui Enzo Moscato elabora drammaturgicamente il racconto La città immaginaria, in cui una visita al caseggiato popolare dei Granili diventa un pellegrinaggio tra il decadimento della razza umana nella sua barbarica piramide gerarchica che attraverso i secoli non ha mutato il volto crudele delle sue leggi sotto la maschera dei tempi.
Mario Martone decide di fare dell’edificio teatrale una camera degli echi, il luogo dell’evocazione, del miracolo visionario che disegna attorno alle teste degli spettatori la spirale infera del mondo. Come in un rito misterico, un rito osceno e odioso, che rimanda allo scantonare malapartiano nella resa napoletana del ’45.
L’enorme cilindro teatrale del Mercadante si svela allora in tutta la sua crudele irrealtà. Un’emiciclo truccato da puttana, coi velluti e le colonnine, e l’altro disarmato, nudo di cemento e piloni, come le pareti di un qualunque parcheggio sotterraneo, un palazzo occupato, un luogo vuoto, che fa il vuoto.
In questo spazio della finzione, della farsa spiritica, nella sua veste sbranata, un gioco di riflessi taglia l’aria con azioni e parole, allucinazioni che sembrano provenire da un altro luogo aprendo squarci sulla realtà cui si riferiscono. In ciò sta l’intuizione geniale del regista che in certi momenti evoca la tremolante sagoma di un’esistenza, col piglio di misteriosa cialataneria comune ai maghi felliniani o all’evocazione di Madama Pace nei Sei personaggi pirandelliani.
La rapida sequenza narrativa segue il ritmo concitato e stappato proprio del racconto a brandelli della Ortese, che non si ferma, trascinata costantemente via dalla mano della sua guida attraverso una realtà che non permette contemplazione.
La corrente dello spettacolo è però alternata. Gira e si integra perfettamente con il movimento intimo del lavoro l’evanescenza di certi dettagli, con la loro implausibilità oggettiva, la costruzione di certe figure. In questo senso incantano Angela Pagano o Gianfelice Imparato, nel ruolo di un Maestro Figheroa ancora più potente nei tratti accennati da Moscato che nella stessa Città involontaria, nella sua totale sradicatezza umana e coi suoi partoriti bambolotti, portati in giro e schiaffeggiati in una culla-carrello.
Appaiono invece eccessivamente pesanti e dense le zavorre naturalistiche che appesantiscono il respiro dell’opera. Ciò è evidente a volte nel linguaggio, e altre volte nella costruzione dell’immagine (come nella scena del funerale), così sussurrata e ombreggiata, confusa nei suoi contorni zoomorfici nella Ortese, così “sceneggiata” in Martone-Moscato, che fa l’effetto di un capodimonte in un teatrino delle ombre.
A parere di chi scrive, è proprio qui il limite fondamentale di questo lavoro. Nel non riuscire a definire con chiarezza e continuità il linguaggio, e dunque gli effetti, attraverso cui si decide di condurre allo spettatore il senso dell’opera. Ed è lo stesso impianto scenografico ad essere un elemento di tolleranza messo talvolta a dura prova, brillando nelle sequenze visionarie, e confliggendo con quelle realistiche. Dimostrando che la legge strutturale di questo spettacolo è appunto il rimando altrove, la rifrazione, l’analogia. Decidere di stare a questo gioco, da parte dello spettatore, significa allora non sentire più la necessità della carne, della caratterizzazione, del grido e accettare anche l’organismo incompiuto nella sua ostentata divisione in segmenti.
L’opera segreta è appunto un trittico, che nella tripartizione vede al contempo il suo limite e il suo pregio. E viene quasi spontaneo domandarsi il perché esso fugga una inevitabile necessità di sintesi fra i tre passaggi, che pure obbediscono ad una unica logica di fondo. E’ Caravaggio stesso, infatti, a fornire la dimensione del sacro (sacer in latino raccoglie entrambi i sensi di negativo e positivo) all’acropoli-necropoli ortesiana abbruttita ed erosa dai secoli. Come infine Moscato, nella sua giubba, la cui consunsione non permette più di distinguervi il prestigiatore di periferia o il gentiluomo decaduto, incarna il pellegrino leopardiano, l’uomo giunto alle pendici del Vesuvio col suo presagio di morte. Suo sarebbe stato naturalmente il ruolo del narratore della seconda parte, in perfetto equilibrio tra sbigottimento e disillusione, tra compromissione ed assenza, nelle cui ombre si sarebbero perse le spigolature di uno sfortunato personaggio di cui è vittima e artefice Giovanna Giuliani.
Ma uscendo, tra le strade che dal porto che si perdono nel cuore febbricitante di Napoli rifletto che sono proprio gli spettacoli incompiuti, sbrindellati, quelli che mi hanno colpito maggiormente. Perché nelle loro spaccature, e mutilazioni, è ancora possibile vedere quella scintilla pura della creazione che raramente riesce brillare attraverso un guscio chiuso, quasi mai perfetto.
|
|
|
|
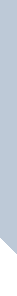 |

 L’ultimo numero di LifeGate Teatro
L’ultimo numero di LifeGate Teatro
|
Pubblichiamo oggi, 30 marzo 2005 l’ultimo numero di LifeGate Teatro, settimanale di teatro e danza che per due anni e mezzo ha compiuto la sua attività editoriale all’interno del progetto LifeGate. Sono stati mesi importanti per noi. Abbiamo cercato di cambiare il modo di fare giornalismo teatrale. Di rifondare la critica italiana cercando di capire quale fosse il suo ruolo in questo presente storico. La nostra sfida non era riuscirci. Era provarci. E forse ci abbiamo provato piuttosto bene.
On-line rimarranno gli archivi di questi due anni. Il lettore “postumo” potrà trovarvi le tracce del nostro lavoro e certamente dei contributi utili alle sue ricerche sul teatro italiano contemporaneo.
Per il numero di chiusura avevamo chiesto ai nostri lettori di scrivere qualcosa su di noi. Alcuni lo hanno fatto. E pubblichiamo i loro piccoli, ma importanti, contributi nei due articoli intitolati Bon nuit. Altri, davvero molti, hanno preferito mandarci messaggi di carattere più strettamente personale, che scegliamo di non pubblicare. Ma li ringraziamo tutti. Quelli di cui riportiamo i commenti e quelli, troppi per poterli citare, di cui conserveremo gli appelli alla resistenza, che per noi sono stimolo di trasformazione.
Per chiudere ci sembrava infine giusto puntare ancora una volta l’obiettivo su un problema centrale, quello che ha dato vita due anni e mezzo fa a questa rivista, ovvero la necessità di esigere di più dalla critica italiana. E un dovere degli artisti e noi ad essi ci rivolgiamo.
- Redazione Teatro -
|
|
| |

|
|