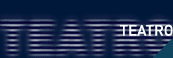 |
| |
Dialogo settimanale su teatro e danza.
ANNO 2026 NUMERO 25
Dal 23/02/2026
al 02/03/2026
Aggiornato il lunedì sera
|
|
 |
 |
 |
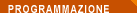 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
| Fatto salvo lo sguardo vergine
|
|
| L’estate.fine, ultimo lavoro delle Ariette ha debuttato al Festival di Santarcangelo.
|
|
|
|
|
di Gian Maria Tosatti
|
|
|
|
|
A volte pesa sul teatro la parola stessa che lo identifica. Gli è zavorra fastidiosissima e inutile. Davvero inutile.
A volte è il teatro a penalizzare il Teatro, ovverosia la sua circostanza, il fatto che vi si assista in una sala specifica che ci “prepara” all’evento che si consumerà, oppure che tale evento, quando fugge la convenzione di uno spazio con palco e platea sia comunque inserito in una cornice di Festival, cioè un più ampio contenitore convenzionale.
Quello che uccide il Teatro è l’attesa. L’aspettativa che si ha di assistere ad uno spettacolo. Ci rifletto in queste settimane e mi pare che ciò, più di ogni altra cosa devii il fuoco dell’evento.
L’aspettativa è un qualcosa che può andar bene per una forma ideale di teatro tradizionale, un teatro di maschere scritto. L’aspettativa è un qualcosa che si giustifica verso i canovacci letterari. Il suo senso cade nel momento in cui sulla scena compare un essere umano.
Un uomo davanti ad altri uomini è cosa che demolisce, spazza via le pareti dell’edificio teatrale. Le pareti di qualsiasi contenitore convenzionale. Lo scambio avviene altrove. Ma bisogna desiderarlo.
Sono personalmente in disaccordo con chi afferma che solo se lo spettacolo è ben fatto si ha “coinvolgimento”. Sono in pieno disaccordo con chi vorrebbe risparmiare allo spettatore ogni sforzo. Uno spettacolo è una relazione. E’ una “cosa a due”. Lo spettatore se la deve cercare, deve lavorare. Deve tendere la mano all’attuante o prendere la sua tesa.
Se questo non accade non è solo colpa degli artisti. Il problema è molto più complesso.
Così rifletto una volta di ritorno dall’ultima creazione del Teatro delle Ariette. Penso che in fin dei conti noi spettatori festivalieri, in quel grande sogno eravamo veramente degli intrusi, dei trapiantati, degli inadatti. Un po’ come lo è il bel garzone nel salotto della nobiltà o lo statista finissimo nel reparto smistamento carni di un macello. Come dire. Gli spettatori col teatro in testa è bene che stiano lontani dai teatri se non ci entrano con una grande umiltà.
L’estate.fine è un piccolo miracolo agreste. E’ uno smarrimento onirico tra le figure che scorrono in una memoria comune che ci preesiste. Ci lascia imbambolati tra il grano turco alto due metri a camminare come quando si era bambini sulle tracce delle vite che ci hanno preceduto, spiati da sagome distorte. Sì, al presente la sensazione di quei ricordi dell’infanzia, con le ripetizioni e le sproporzioni. Di tempi e simultaneità inconcepibili. Di identità fantasticate.
Una donna che coglie i fagiolini come una stregona di periferia con appese in testa le lastre di una probabile malattia. Le lastre che scorrono, cambiano posto. Le lastre viste sul tavolo della cucina di mia nonna in una trasfigurazione continua di fatti e toni, di espressioni che ci vengono sottratte solo un attimo prima che le si possa catturare. Proprio come in quegli incubi calmi, che lasciano al risveglio un dolore dolciastro. Ed è bello restare lì stupefatti, che in mezzo ad un campo di grano turco si consumi un rito popolare, una grottesca festa dalla rarefatta allegria. Una sagra innaturale, quasi violenta nel suo costringerci alla liturgia.
Ma queste non sono le osservazioni di un visitatore. Sono piuttosto i nodi di un’analisi strutturale compiuta nei confronti di un lavoro difficilissimo. Che cerca di comporre una sinfonia non sulle note dirette, ma sugli echi che quelle note producono. Una tessitura a maglie larghe fatta di risonanze, di simboli riflessi in un voluto scivolar via dello spazio. L’estate.fine è il tentativo di ricreare la sensorialità del ricordo sognato, tra verosimiglianza e assurdo. La compagnia bolognese sta attenta a contrappuntare elementi distillati, non lascia niente al caso, ne è prova il campo di 6000 mq in cui l’azione si svolge. Campo che per due mesi ha impegnato il gruppo nelle operazioni di coltivazione per avere una creatura perfetta, viva, impagabilmente suggestionante.
Un allestimento estemporaneo, realizzato grazie al coraggio della compagnia e del Festival di Santarcangelo che lo ha prodotto. E’ vero, lo spettacolo mostra ancora alcune debolezze, ma non potrebbe essere altrimenti. Le Ariette innescano un metodo drammaturgico radicalmente nuovo, sviluppato a partire da alcune scoperte registrate nel corso dei precedenti lavori. Danno a questo metodo una forma indipendente attraverso la costruzione di uno spettacolo. E’ questo il valore.
Non si può parlare di spettacolo perfetto (e sarebbe stupido pretenderlo, sarebbe come dire che le repliche successive al debutto non servono all’auto comprensione del lavoro), ma di “tentativo” perfetto.
Qui, per l’analista sta il valore di ciò che si è potuto vivere e vedere. Per il pubblico capitato a Santarcangelo per caso, per il pubblico vero, che non si aspetta niente, il valore sta nel viaggio a occhi aperti in quei territori che da svegli ci sono proibiti.
|
|
|
|
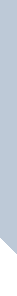 |

 L’ultimo numero di LifeGate Teatro
L’ultimo numero di LifeGate Teatro
|
Pubblichiamo oggi, 30 marzo 2005 l’ultimo numero di LifeGate Teatro, settimanale di teatro e danza che per due anni e mezzo ha compiuto la sua attività editoriale all’interno del progetto LifeGate. Sono stati mesi importanti per noi. Abbiamo cercato di cambiare il modo di fare giornalismo teatrale. Di rifondare la critica italiana cercando di capire quale fosse il suo ruolo in questo presente storico. La nostra sfida non era riuscirci. Era provarci. E forse ci abbiamo provato piuttosto bene.
On-line rimarranno gli archivi di questi due anni. Il lettore “postumo” potrà trovarvi le tracce del nostro lavoro e certamente dei contributi utili alle sue ricerche sul teatro italiano contemporaneo.
Per il numero di chiusura avevamo chiesto ai nostri lettori di scrivere qualcosa su di noi. Alcuni lo hanno fatto. E pubblichiamo i loro piccoli, ma importanti, contributi nei due articoli intitolati Bon nuit. Altri, davvero molti, hanno preferito mandarci messaggi di carattere più strettamente personale, che scegliamo di non pubblicare. Ma li ringraziamo tutti. Quelli di cui riportiamo i commenti e quelli, troppi per poterli citare, di cui conserveremo gli appelli alla resistenza, che per noi sono stimolo di trasformazione.
Per chiudere ci sembrava infine giusto puntare ancora una volta l’obiettivo su un problema centrale, quello che ha dato vita due anni e mezzo fa a questa rivista, ovvero la necessità di esigere di più dalla critica italiana. E un dovere degli artisti e noi ad essi ci rivolgiamo.
- Redazione Teatro -
|
|
| |

|
|