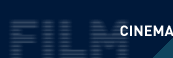 |
| |
Sul grande schermo
di LifeGate.
|
|
 |
 |
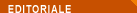 |
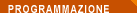 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
| Blue Soviet: documentari e fiction |
|
| Film in cui si è voluto mostrare come l'uomo possa essere in grado di distruggere un ecosistema, sovente per suoi interessi personali, o credendo che ciò possa essere di aiuto in qualche modo. |
|
|
|
|
di Sergio Ragaini
|
|
|
|
| |
Gli orrori di un nucleare fuori controllo, e l'incuria ambientale possono, come sappiamo, portare conseguenze tremende sull'ambiente. Qui le conseguenze sono apparse davvero in tema con il titolo della rassegna. In diversi casi, lo spirito delle descrizioni calcava necessariamente su toni forti, accesi, mettendo l'accento sulle persone, sulle loro sofferenze, sul sentirsi impotenti di fronte a quanto stava accadendo.
Chernobyl, cronaca di una settimana difficile, di V. Shevcenko (1986) appare interessante non tanto per quanto viene detto, ma per il modo con cui il tutto viene raccontato. La tragedia emerge in tutta la sua durezza, in tutto il suo aspetto di distruzione ambientale. Tuttavia, poco si indaga sulle cause dell'esplosione, e poco a fondo si va sui rischi della radioattività, che così duramente hanno poi esteso le loro conseguenze a buona parte dell'Europa (come molti possono ricordare). Il tono è sì documentaristico, ma ancora una volta autocelebrativo, mettendo in risalto la capacità della struttura di reagire in modo efficace, l'eroismo di chi ha dato la vita per fare in modo che la situazione potesse normalizzarsi, la qualità degli interventi effettuati. Ma non mettendo in risalto la poca sicurezza della centrale, le condizioni precarie in cui i lavoratori si trovavano, la poca consapevolezza o, peggio, la trascuratezza in tema di rischi, nonostante si sapesse dei problemi che uno scoppio di un reattore avrebbe comportato anche a territori geograficamente più lontani.
Un documentario, quindi che tende a mostrare un realismo relativo, ma che ha comunque il merito di una, almeno parziale, autocritica.
Per contrasto è stato poi proiettato Once upon a Time, di Galina Adamovic (Bielorussia ; 2001). A 15 anni dal disastro, gli studenti di Mendrisio hanno realizzato una sorta di reportage, dove le voci sono assenti e le immagini solo parlano, cariche di drammaticità. Le riprese degli stessi luoghi del documentario precedente, ancora disastrati e senza vita, mostrano la verità, stavolta senza veli, su una tragedia che lascerà il segno ancora per lungo tempo. Una dimostrazione chiara di come l'Uomo, quando si spinge oltre quelli che sono limiti naturali di gestione ambientale, e lo fa senza curarsi delle conseguenze, può essere troppo facilmente sopraffatto da eventi che, a questo punto, non sarà più possibile gestire, perché completamente sfuggiti di mano. Immagini crude nella loro naturalezza estrema, ma che aiutano a riflettere, dove i suoni che si ascoltano e quanto si vede sullo schermo ha sovente il sapore della morte, della desolazione e dell'assenza di vita.
Nucleare ricco di rischi anche quando è, sulla carta, controllato e controllabile. È quanto mostra "Poligon", di Vladimir Rerikh e Oraz Rymzanov (Kazakhstan , 1990). Il dramma degli esperimenti nucleari, sovente propagandati come "sicuri", ma che, al di là di quanto possono dire o voler mostrare, portano con loro enormi carichi di distruzione. Il poligono in questione è quello nucleare, designato agli esperimenti, di Semipalatinsk, nell'Asia Centrale. Un luogo designato come "sicuro", ove i danni sull'ambiente erano ritenuti minimi.
In realtà, le immagini spesso riprese di nascosto mostravano una realtà ben diversa. Un vento radioattivo che soffiava, cancellando ogni forma di vita sul proprio cammino, eliminando il soffio vitale da ogni cosa che si trovava sulla sua strada, e lasciando dietro di sé un grandissimo carico di morte, ove la vita non sarebbe tornata possibile se non dopo molti anni.
Molte volte, nel filmato, apparivano le versioni contrastanti di chi si raccontava: i capi dell'Esercito, che insistevano sulla necessità e sicurezza di questi esperimenti, e le persone, raccontanti, ad anni di distanza, le sofferenze e il carico di morte che invece ne derivava. Quanto si vedeva sullo schermo aveva dell'incredibile: intere famiglie distrutte, l'incidenza della sindrome di Dawn addirittura tripla, persone nate deformi ancora a anni di distanza. Oltre ai racconti sui capi di bestiame uccisi dalle esplosioni, e a quelli completamente deformati dalle radiazioni.
Tutto questo non è poi così lontano da quanto accade nel mondo occidentale. Il discorso sull' Associazione Semipalatinsk - Nevada è emblematico nel dire che quanto abbiamo visto avviene anche nel democratico Occidente, ove spesso, addirittura, questi esperimenti vengono condotti in luoghi al di fuori dei propri territori, impedendone poi, per decenni, uno sviluppo normale, e provocando danni incalcolabili e spesso irreversibili sulla flora e sulla fauna, oltre che sull'ecosistema in generale.
Naturalmente, i leader militari propagandavano la cosa come necessaria, come un sacrificio in nome della pace. Ma, ci chiediamo, la pace può avvenire attraverso la distruzione di un ecosistema, o piuttosto deve avvenire attraverso la comprensione reciproca? La risposta appare ovvia, ma purtroppo non per tutti, in particolare per chi crede che l'equilibrio del terrore sia il modo migliore per ottenere la pace. Forse, in tal senso, si dimentica che un'arma che, quando si ha a disposizione un'arma di qualsiasi tipo, vi è comunque la probabilità che questa, seppur in un momento di follia, venga utilizzata, con conseguenze, a questo punto, davvero catastrofiche.
Catastrofi ambientali, spesso imprevedibili e incalcolabili, ma tenendo conto dell'interazione di tutti gli ecosistemi, con l'ombra di un sospetto di alterazione del territorio. È quanto mostrato in Joctau, cronaca di un mare morto, di Sergej Azimov (Kazakhstan, 1989 / 90). La catastrofe ambientale descritta è quella legata all'estinzione del Mare interno d'Aral. Questo mare ha perso, dal 1970 ad oggi, circa il 70% della sua superficie. Il titolo risuona già carico di tristezza e di morte. Joctau, infatti, è il pianto legato alla cerimonia di sepolutra dei morti. Un pianto qui per la morte di un mare, portatore di vita, che ora, scomparendo, lascia solo desolazione e sconforto, oltre che lasciare assenti forme di sostentamento per le popolazioni che vi vivevano vicino.
Le immagini dei luoghi dove prima pulsava il rumore dell'acqua, con il suo carico di vita, ora ridotti a deserto, le navi in secca sul nulla, tali da far ritenere incredibile il fatto che un tempo esse solcavano acque pescose, si alternano alle voci della gente, al loro vero pianto, alla tristezza nel ricordare com'era e com'è il luogo in cui vivono, alle loro descrizioni di come sia ormai impossibile abitare lì.
Poi, racconti di opere per dragare altri fiumi, per riportare acqua laddove non vi è altro che sabbia e deserto. Lavori che, però, non hanno dato i frutti sperati, sconvolgendo, almeno in parte, ulteriormente l'ecosistema.
La speranza aleggia ancora sui volti delle persone: essi sperano che, come se ne è andato, il mare possa tornare. Ma, purtroppo, quanto accaduto appare irreversibile e, tra l'altro, progressivo. Il mare si ritira sempre di più, e la vita su quelle terre potrà divenire presto impossibile.
Un film denuncia del periodo immediatamente successivo all'Unione Sovietica. Un film per capire davvero quanto l'equilibrio in cui viviamo è delicato, e quanto noi abbiamo bisogno di questo equilibrio per le nostre vite.
Interessante è stato, dopo il film, poter assistere alla conferenza del professor Riccardo Petrella, Docente di Ecologia Umana a Mendrisio, sul tema: Il bene comune: acqua e diritto alla Vita. Un incontro, a tutti gli effetti, parte integrante del festival.
Interessante, insolito e dal linguaggio decisamente innovativo è stato il cortometraggio Puschkin Lift, dello svizzero Hugo Shär (Ucraina; 2003). Il regista era presente, tra l'altro, in sala.
Una serie di immagini dotate di grande lirismo e poesia, per una discesa verso le miniere di carbone di Gorlovka, a 1200 metri di profondità. Un'ascensore che, nella sua discesa quasi irreale, trascina tutto, e tutto coinvolge in una sorta di gorgo senza fine. Canti ortodossi, eseguiti con grande suggestione da un trio di cantori, fanno da sfondo a immagini quasi disumanizzanti, a tratti frenetiche e a tratti più liriche e meditative, che divengono quasi sospese in una realtà quasi dissolta, evanescente, dissolvenze ad introdurre quadri di vita, situazioni di apparente normalità, forse per farci riflettere su cosa si nasconde dietro le pieghe di una realtà al di là delle apparenze, al di là della percezione. L'aspetto metapercettivo, infatti, si nota con forza dietro le immagini, e la tendenza a volerci far andare oltre risulta vincente, in qualcosa che trascina e cattura lo sguardo e ogni percezione.
Apertura alla speranza, poi, con l'ascensore che risale. Forse verso un nuovo modo di vedere le cose, ed un nuovo modo di concepire il rapporto con l'ambiente e con le persone.
La sezione dedicata alla fiction ha presentato i suoi momenti davvero più forti, dove l'aspetto delirante e apocalittico ha preso forma in tutti i suoi possibili risvolti.
Scenari, naturalmente, non reali, e frutto di proiezioni fantastiche, ma con un forte fondo di verità possibile. La parte dedicata ai documentari ha ampiamente dimostrato cosa può accadere quando le situazioni sfuggono letteralmente di mano all'Uomo. La parte dedicata alla fiction ha proiettato conseguenze estreme, ma purtroppo non impossibili (anche se, si spera, fortemente improbabili).
Due i lavori presentati.
Il primo, Lettere di un uomo morto, di Konstantin Lopuschanskij (Urss ; 1986) traccia lo scenario di un ipotetico "Day after", dopo un'esplosione nucleare. Il suo carattere, ed il modo con cui la descrizione è stata effettuata dal regista, sono al limite dell'allucinazione e dell'irrealtà. Su rumori che sembravano provenire da un altro mondo viene mostrata un'umanità sommersa, costretta ad una vita sotterranea, senza più speranze per il futuro e, probabilmente, senza più un futuro possibile a cui pensare. Un'umanità per la quale la luce è inesistente, data solo da piccole e fioche lampadine alimentate da dinamo azionate a pedali. Una visione claustrofobica, dove di luce ne si vede davvero poca. Alle immagini inquietanti di un sottosuolo, si alternano immagini incredibili di un mondo esterno, dove la vita è impossibile e dove la lotta anche per i beni più insignificanti e normali, oltre che per le medicine più elementari (quali gli analgesici) si sono fatte sempre più cruente.
Immagini incredibili su un mondo in via d'estinzione, su un'umanità ormai alla fine, che si attacca, in parte, a ciò che rimane della vita e, in altri casi, con lucidità inquietante quanto drammatica, dichiara tutto finito e si affida alla morte come liberazione finale.
Un film che, senza dubbio, ha lasciato attoniti gli spettatori, per la freddezza quasi didascalica con cui il racconto prendeva forma, verso un qualcosa di sempre più inquietante, di sempre più sprofondante verso il nulla; tappa ultima e, purtroppo, inevitabile di tutta la situazione mostrata.
Immagini di qualcosa che va a morire, di desolazione, di fine anche nel secondo dei film proposti, Aynalajn, di Bolat Kalymbekov (Kazakhstan ; 1990), proiettato per la prima volta nell'Europa Occidentale. La lenta fine di un villaggio del Kazakhstan, descritta attraverso i suoi personaggi. Sullo sfondo, ancora una volta, una situazione che ricorda la scomparsa del Mare d'Aral (reale o proiettata, ma l'accenno appare evidente), e quella dell'inquinamento dovuto all'industria, e, forse, ai test nucleari. Inquinamento che sembra avere la responsabilità del lento declino del luogo, ridotto ormai senza alcun mezzo di sussistenza.
Immagini lente, a tratti sospese, per situazioni che non vengono direttamente commentate. L'autore vuole che, chi osserva, giudichi da sé. Una vicenda in cui non accadono molte cose. Perché molte cose sono già accadute, e poche altre ne potranno davvero accadere ancora. Immagini che, anche qui, mostrano uno sprofondare verso l'annientamento, verso l'annichilimento individuale ed ambientale, sullo sfondo di un ambiente che non è più in grado di fornire nulla, se non desolazione.
Indietro |
|
|
|
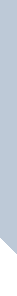 |

 Cinema "Oltre il Cinema" di scena nei comuni della provincia di Como
Cinema "Oltre il Cinema" di scena nei comuni della provincia di Como
|
| Una rassegna di Cinema per "Andare oltre". Per guardare anche alla Società, a quello che ci circonda, con occhio attento e critico. Questo lo scopo della rassegna "oltre lo sguardo". Dal 9 ottobre 2004 al 28 maggio 2005, in diversi comuni del comasco, saranno proiettati film di qualità, uniti ad interventi di rappresentanti del mondo del Sociale i quali, prendendo spunto dal film, tratteranno tematiche spesso ignorate, ma degne di essere conosciute e valorizzate. Tessera dalla cifra simbolica, che dà diritto a tutte le proiezioni.
Info:
Coordinamento Comasco per la pace - www.comopace.org ; [email protected]
Oltre lo sguardo - www.ecoinformazioni.rcl.it ; [email protected]
|
 Addio Janet Leigh
Addio Janet Leigh
|
| "Sì, dopo aver girato Psycho non fece mai più la doccia. No, l’acqua non era fredda, Hitchcock si premurò perché la doccia gettasse acqua calda per tutti i 7 giorni di riprese necessari per la scena... Sì, lei era nuda sotto la doccia, ma in nessuna inquadratura, per quanto brevissima, si vedono i capezzoli: problemi di censura, in quel lontano 1960.
Bisogna partire da lì, da quella scena - una delle tre o quattro più famose della storia del cinema - per raccontare la vita di Janet Leigh, morta ieri all’età di 77 anni".
È morta "serenamente, a casa sua" l'attrice americana Janet Leigh. La notizia è stata data dal portavoce della figlia: Jamie Lee Curtis è stata al capezzale della madre insieme all'altra figlia, Kekky, e a Robert Brandt, secondo marito di Janet Leigh. Dal 1951 al '62 l'attrice era stata moglie di Tony Curtis. Tra i molti film interpretati, 'Safari', 'L'infernale Quinlan'. |
|
| |

|
|